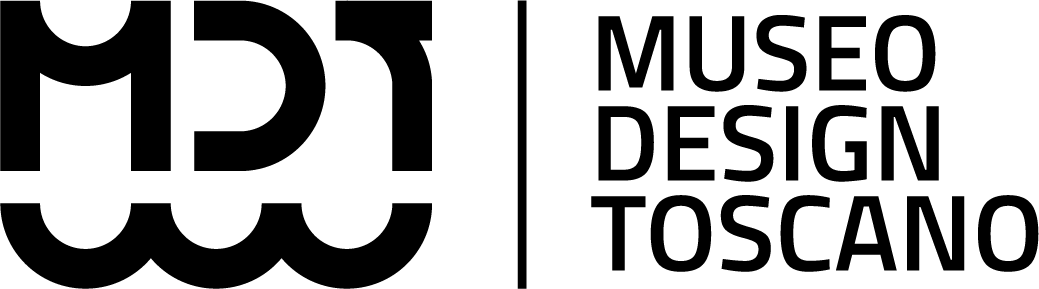Quando si parla di “industrial design” nel senso più rigoroso e operativo del termine, gli strumenti di precisione rappresentano un banco di prova particolarmente rivelatore: non c’è spazio per la retorica della forma, perché la forma è chiamata a rendere leggibile un sistema di funzioni, a garantire stabilità, sicurezza, continuità d’uso e coerenza tecnica nel tempo. In questo quadro si colloca con grande chiarezza la famiglia dei microscopi Officine Galileo della serie LGT, sviluppata nel secondo dopoguerra e capace di mostrare, anche a distanza di decenni, un metodo progettuale sorprendentemente maturo. Il caso più noto è il modello LGT/2, premiato con il Compasso d’Oro nel 1959. Ciò che rende questo microscopio particolarmente significativo dal punto di vista del progetto non risiede in una innovazione dei principi ottici, quanto piuttosto nella qualità dell’impostazione complessiva dell’oggetto. Il valore emerge nella coerenza dell’insieme, nella previsione sistematica delle parti, nella relazione ordinata fra componenti funzionali, struttura e accessori, secondo una logica di progetto che supera il singolo modello per configurarsi come piattaforma industriale. Il valore sta nella disciplina: una forma unitaria, non casuale, che deriva dall’aver previsto a priori l’insieme delle parti e delle possibili configurazioni d’uso. Il microscopio, qui, non è trattato come “pezzo singolo”, ma come piattaforma. La serie LGT lascia intuire un pensiero di gamma: componenti, accessori e varianti che si compongono secondo una logica chiara, con attacchi e compatibilità progettati non come compromessi dell’ultimo minuto, ma come strategia. È una differenza decisiva: la coerenza non riguarda solo la silhouette, riguarda l’ecosistema. Due elementi, in particolare, lo rendono evidente. Il primo è la possibilità di sostituire il tradizionale tubo mono o binoculare con un visore che consente la condivisione dell’osservazione con più persone. È un dettaglio che racconta un’attenzione rara per il contesto reale della ricerca: il lavoro scientifico è spesso lavoro di gruppo, fatto di confronto e verifica collettiva. Progettare la condivisione della visione significa progettare un comportamento, non solo un apparecchio. Il secondo elemento è la relazione intelligente con gli accessori: l’illuminatore dedicato (destinato a ricerca, clinica o metallografia) appare come un oggetto “onesto”, concentrato sulla prestazione e privo di sovrastrutture seduttive. Alette di dissipazione, filtri, proporzioni sobrie: tutto concorre a dare un’immagine di chiarezza e controllo. Ma la cosa più importante è che questo accessorio non vive isolato: è pensato per innestarsi con naturalezza nel sistema Galileo, valorizzando un prodotto già esistente attraverso una nuova rete di connessioni. La stessa mentalità si riconosce anche nel collegamento con la mini-fotocamera GaMi 16, per la quale viene previsto un adattatore capace di trasformare il microscopio in uno strumento di documentazione rapida, accessibile e relativamente economica. Non è solo una “comodità”: è una dichiarazione di metodo. Significa ragionare in termini di interoperabilità e continuità di strumenti, come farebbe un’industria consapevole. Tutto ciò rimanda a un centro progettuale interno capace di impostare regole sintattiche e produttive, più che “disegnare belle forme”. La figura di Ambrogio Carini, legata alla sezione milanese e alla regia di quei progetti, suggerisce l’esistenza di una cultura aziendale orientata al progetto come lavoro corale: progettisti, tecnici, produzione e uso finale tenuti insieme da una logica ferrea di coerenza e componibilità. E forse è proprio questa la ragione più profonda per cui un riconoscimento attribuito a un singolo modello appare riduttivo: ciò che meriterebbe attenzione museale è l’impianto di gamma, la visione sistemica che lo rende possibile.