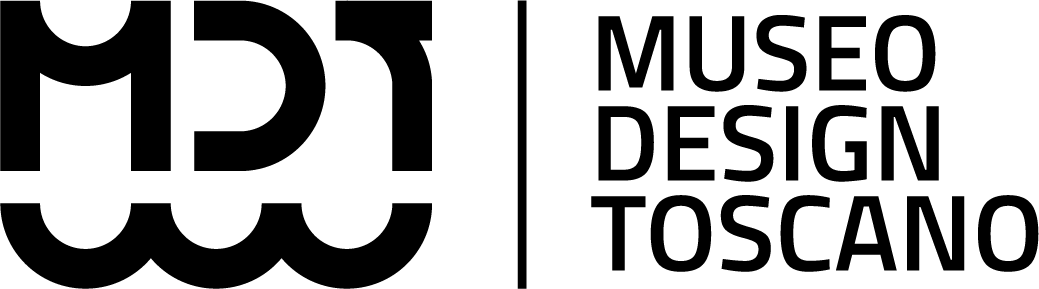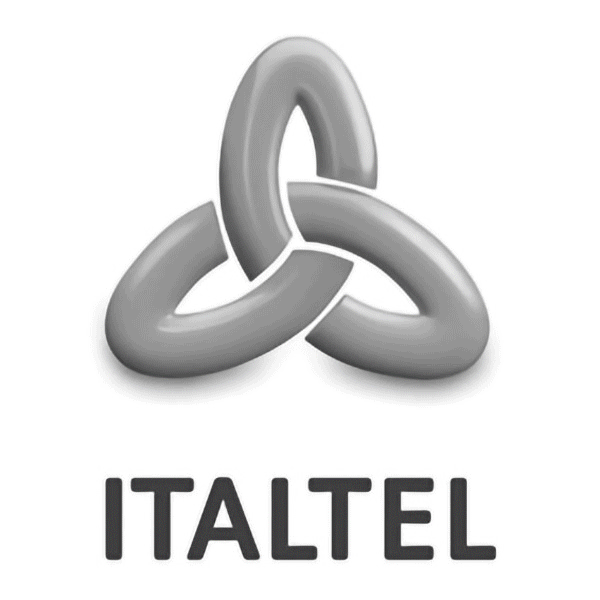Nel giro di pochi anni, tra la fine degli Ottanta e l’inizio dei Novanta, la casa italiana scopre un paradosso nuovo: la comunicazione diventa più veloce eppure aumenta l’ansia di “perdere” qualcosa. La segreteria telefonica – oggetto nato per governare l’assenza – si colloca esattamente in quella frattura: non è ancora internet, ma non è più soltanto telefono. È una soglia domestica che registra, conserva, rimanda indietro una presenza; e lo fa con una ritualità che, oggi, appare sorprendentemente concreta. È in questo punto di passaggio che si colloca Mirage (1991), una delle prime segreterie digitali comparse sul mercato italiano. La sua novità tecnica è chiara: eliminare il nastro e affidare l’intero ciclo di registrazione e gestione a una logica elettronica. Ma il merito più interessante, visto con lo sguardo del progetto, non è il salto prestazionale in sé – destinato, come ogni innovazione, a diventare rapidamente “norma” – bensì il modo in cui quella discontinuità viene resa accettabile, leggibile, persino familiare. Mirage sceglie infatti una figura plastica che non ostenta la smaterializzazione digitale, bensì la “trattiene” entro un impianto stabile e archetipico: un corpo compatto, rilevato, impostato su un’inclinazione che non è vezzo ma regia percettiva. Il piano principale non si limita a ospitare comandi e display: funziona come facciata, come fronte riconoscibile che ordina l’attenzione e suggerisce una gerarchia d’uso. In un oggetto che gestisce messaggi – quindi tempo, attesa, ritorno – la forma diventa, prima ancora della funzione, una piccola macchina di orientamento. La scelta di non adagiare la segreteria in una scatola neutra, ma di darle un profilo quasi “micro-architettonico”, risponde anche a un’esigenza culturale specifica: la transizione italiana verso i dispositivi domestici “autonomi” è lenta, prudente, filtrata. Negli stessi decenni in cui altrove si normalizzano tecnologie e servizi accessori, in Italia pesano ancora vincoli infrastrutturali, monopolio e abitudini sociali: la casa spesso non è vuota, la reperibilità non è un’ossessione generalizzata, e la telefonia come consumo di massa arriva tardi. È proprio per questo che, quando il mercato si apre, non basta una novità tecnica: occorre un oggetto che sappia mettere in scena la propria ragione d’essere senza risultare alieno. Qui Mirage mostra una consapevolezza rara: invece di promettere “futuro” come estraneità, costruisce una continuità visiva con un repertorio domestico già interiorizzato. La sua sagoma inclinata, la scansione delle superfici, l’ordine dei segni e dei volumi richiamano – senza citazioni pedanti – il mondo delle radio e degli apparati sonori del dopoguerra, cioè il grande archivio domestico delle “scatole parlanti”. Non è nostalgia: è strategia. È il tentativo di dare al digitale un corpo che non sembri un puro evento elettronico, ma un oggetto con peso, postura, presenza. Anche l’interfaccia segue questa logica. Le funzioni principali sono concentrate in alto, dove la mano arriva in modo naturale; le secondarie scivolano sui fianchi; ciò che è antiestetico o disturbante (cavi, prese, connessioni) resta nella zona d’ombra, come se il prodotto volesse dichiarare: il disordine tecnico non riguarda l’utente, riguarda il retrobottega dell’oggetto. È un dettaglio rivelatore, perché anticipa una tendenza che diventerà dominante: la tecnologia cresce, ma la sua complessità deve sparire dalla scena. Il progetto porta la firma di Carlo Fontana, che arriva alla telefonia dopo una lunga frequentazione del mondo hi-fi: non stupisce dunque che Mirage ragioni come ragiona un buon apparecchio sonoro, cioè come un dispositivo che deve predisporre un comportamento, un tempo, una postura. Qui l’ascolto non è un “clic” astratto: è un piccolo rito domestico in cui la forma guida l’azione, e l’azione conferma la forma. Sul piano produttivo Mirage è anche un segnale precoce di filiere già globalizzate: viene realizzato da Akada International Corporation (Taiwan), importato dalla livornese Master e commercializzato in Italia da Italtel Telematica. Un oggetto che, pur destinato alla normalità della casa e dell’ufficio, nasce in un incrocio internazionale dove progetto, produzione e mercato smettono di coincidere in un unico luogo: un aspetto oggi ovvio, ma allora ancora indicativo. Visto oggi, Mirage non si difende come semplice “tappa” di una genealogia tecnica destinata a essere superata; si difende come documento di passaggio: la prova che, nel design, l’innovazione non entra nella vita quotidiana solo perché funziona, ma perché sa assumere una forma che la renda abitabile. È questa qualità – la capacità di dare corpo e grammatica a una tecnologia che stava perdendo materia – che giustifica pienamente la sua presenza in una collezione: non come reperto nostalgico, ma come caso esemplare di come il progetto riesca, talvolta, a trasformare un salto tecnico in cultura domestica.