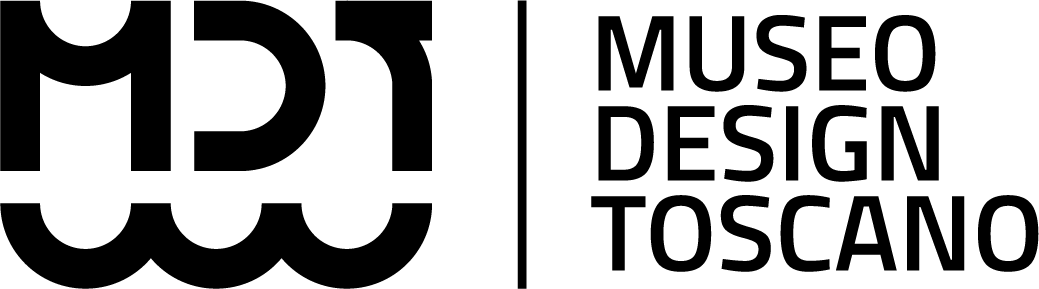Il SAPI nasce dove l’architettura incontra il suo limite più duro: il tempo. Non il tempo lento del progetto e del cantiere, ma quello brutale dell’emergenza, quando una comunità perde in poche ore case, servizi, riferimenti, e la domanda non è “costruire”, bensì restituire vita abitabile senza fingere che bastino una tenda o un container. Tra il 1982 e il 1983 Pierluigi Spadolini elabora, nel perimetro operativo di Italstat, un’idea tanto chiara quanto rara nel panorama italiano: non una “casetta provvisoria” e nemmeno una soluzione adattata all’ultimo minuto, ma un sistema capace di ricostruire con rapidità e dignità l’ossatura minima di un borgo, includendo residenze, funzioni collettive e servizi tecnici. È un progetto che, paradossalmente, ha avuto un destino da oggetto fantasma: riconosciuto, sperimentato, perfino esportato, e poi progressivamente inghiottito da trasformazioni industriali e istituzionali che ne hanno dissolto continuità e memoria. La parola “provvisorio” si porta dietro un equivoco. In teoria significa temporaneo; nella realtà italiana ha spesso significato precario. E la precarietà, quando si parla di abitare dopo una calamità, non è un dettaglio: è una condizione psicologica e sociale che si somma alla perdita. Già nel Novecento la ricerca internazionale ha attraversato più volte il tema dell’emergenza abitativa, dalle ipotesi sul minimo esistenziale alle sperimentazioni postbelliche su strutture leggere e trasportabili; quasi sempre il nodo non è tanto progettuale quanto industriale e organizzativo. Un sistema d’emergenza funziona solo se esiste una filiera in grado di produrlo in officina, stoccarlo, manutenerlo e dispiegarlo con logiche certe. Senza un partner “convinto”, l’emergenza resta il territorio della soluzione adattata e del compromesso permanente. La sequenza Friuli 1976 e Irpinia 1980 rende evidente un punto ulteriore: un Paese sismico non può trattare ogni sisma come un evento imprevedibile nel senso politico del termine. L’emergenza richiede comando e coordinamento, ma ha bisogno anche di una seconda fase, più lunga e delicata: sostituire in tempi rapidi il ricovero immediato con un insediamento transitorio davvero abitabile. Qui matura la riflessione di Giuseppe Zamberletti, che dopo aver gestito sul campo problemi logistici e sociali enormi comprende come la catena “tenda → roulotte → prefabbricato qualunque” produca costi elevati (economici e umani) e un degrado progressivo della dignità del vivere. La tenda serve, ma deve durare poco. Subito dopo occorre uno strumento già predisposto, controllato dallo Stato, riutilizzabile, rapido, capace di ricostruire non solo tetti ma un principio di comunità. La richiesta viene indirizzata a Italstat, holding pubblica per infrastrutture e assetto del territorio, allora l’interlocutore più solido per tradurre un’urgenza civile in un programma operativo. Con Ettore Bernabei alla guida, Italstat decide di non archiviare l’idea come utopia costosa e attiva un percorso di studio e sperimentazione. Nel gruppo dei consulenti si trova Spadolini: architetto, docente, protagonista della Tecnologia dell’Architettura, ma soprattutto progettista con mentalità da industrial designer. Qui sta la chiave. Il punto non è disegnare una casetta: è cambiare registro. Una casa d’emergenza efficace deve essere un prodotto, non un’opera edilizia alleggerita. Le richieste iniziali sono severe e concrete: ingresso protetto, trasportabilità su gomma e rotaia (e, per casi estremi, anche elitrasporto), prontezza all’uso, montaggio senza personale specializzato, riutilizzo, immagazzinabilità. Le ricerche su casi internazionali non offrono un modello da copiare, ma confermano che l’unica via è la produzione “da fabbrica”, con componenti finite, logistica chiara e messa in opera breve. Spadolini stringe allora un patto progettuale insolito: ragionare da architetto sui requisiti ambientali e sul senso della casa; da tecnologo sulla dotazione impiantistica e sui servizi; da designer sulla costruibilità industriale, sui materiali, sulle fasi d’uso e di montaggio. Nasce così il fulcro del sistema: un modulo che si espande senza dipendere da meccanismi fragili e senza trasformarsi in macchina complessa. Il sistema si fonda su un’unità base pluriuso (MPL), che nella configurazione residenziale assume la denominazione MAPI. La logica è rigorosa: il volume chiuso deve rispettare dimensioni compatibili con trasporti ordinari; una volta posato, deve triplicare la superficie utile con un gesto semplice, rapido e ripetibile. Il modulo, in due lunghezze compatibili con standard internazionali, viaggia senza procedure eccezionali; in assetto aperto raggiunge una superficie sorprendentemente generosa per un dispositivo d’emergenza. Struttura metallica e pannelli leggeri (vetroresina/isolante) dichiarano senza ambiguità l’impostazione industriale: robustezza, manutenzione, ripetibilità, finitura in officina. L’intelligenza vera sta nella sequenza di apertura: pannellature esposte all’esterno durante il trasporto diventano pavimentazione nella fase aperta, con la faccia esterna rivolta verso il terreno. Ciò che potrebbe graffiarsi o rovinarsi nel viaggio viene “scaricato” dove non disturba, evitando ripristini. Il posizionamento avviene senza fondazioni grazie a piastre e martinetti che assorbono fuori-piano e stabilizzano. Il dispiegamento è manuale, governato da un’unica manovella, e può essere completato in tempi rapidi. Il risultato formale non è neutro né casuale: tetto a due falde, ingresso arretrato, finestre con schermature. È una scelta psicologica prima ancora che estetica: assomiglia a una casa. E in emergenza assomigliare a una casa è già una forma di cura. All’interno il modulo non arriva vuoto: ospita arredi e dotazioni; nella parte centrale concentra impianti e, quando residenziale, anche la cucina; il bagno è un blocco prefabbricato sostituibile dall’esterno. La distribuzione è flessibile, con varianti per nuclei familiari diversi o per destinazioni non abitative. SAPI però non è la somma di molte unità: è un sistema di aggregazione. Prevede moduli connettivi che consentono composizioni lineari o cruciformi e un impianto di servizi semoventi per energia, acqua, raccolta liquami e rifiuti, illuminazione e viabilità temporanea. L’obiettivo è esplicito: non “parcheggiare” persone in attesa, ma costruire un’insediabilità transitoria con funzioni collettive e una gerarchia minima degli spazi, capace di reggere il tempo lungo della ricostruzione. Il progetto viene prototipato, verificato anche in scala reale, documentato da un filmato oggi irreperibile, e avviato alla produzione nella galassia Italstat. Nel 1987 arriva il Compasso d’Oro: riconoscimento raro e centrato, perché individua ciò che qui conta davvero, cioè il livello di industrializzazione, il comfort e la qualità d’immagine applicati a un campo dove normalmente si accetta il minimo indispensabile. Eppure la storia non segue una traiettoria coerente. Il sistema non diventa lo strumento stabile della protezione civile italiana. Un impiego emblematico avviene fuori dai confini: dopo il terremoto in Armenia (Spitak, dicembre 1988) l’Italia invia un insediamento realizzato con il sistema, dando vita al “Villaggio Italia”. È un episodio che conferma affidabilità e qualità abitativa, ma rende anche evidente il paradosso: un dispositivo concepito per essere predisposizione permanente viene utilizzato come eccezione. L’oblio non ha cause progettuali. Ha cause “di struttura”: la dissoluzione degli assetti industriali pubblici che lo avevano reso possibile. In pochi anni Italstat viene liquidata, assorbita, ristrutturata; società operative cambiano pelle; diritti e cataloghi migrano; filiere si frammentano. Il prodotto sopravvive in brochure e adattamenti, talvolta persino in versioni specialistiche, ma perde progressivamente il suo centro: l’idea originaria di un sistema pubblico pronto all’uso e, insieme, la traccia limpida della sua paternità culturale. Quando inoltre cambiano requisiti dimensionali e standard richiesti, il modulo perde appetibilità di mercato. È una fine quasi ironica: un progetto nato per sottrarre l’emergenza all’improvvisazione viene stritolato da mutazioni organizzative e normative, più che da limiti tecnici. Resta così uno dei rarissimi casi italiani in cui l’emergenza è stata trattata come materia alta: non solo riparo, ma città minima; non solo prefabbricazione, ma prodotto industriale; non solo logistica, ma psicologia dell’abitare. Nel percorso di Spadolini è un progetto che mette in crisi le categorie: architettura che si comporta da design, e design che si assume il compito di dare forma a una comunità. E proprio per questo, al di là delle sparizioni d’archivio e delle vicende industriali, merita oggi di essere riletto per ciò che è stato: una macchina per la normalità, progettata esattamente nel punto in cui la normalità si spezza.